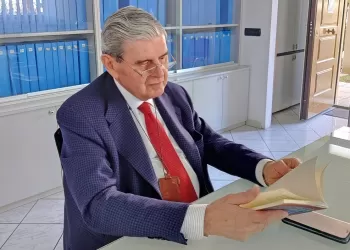di Silvio Di Giovanni
[img align=left]http://www.lapiazza.rn.it/settembre/cattolica_fronte.jpg[/img]
Cattolica 1945-46. Incontro di calcio con la squadra dei militari inglesi nel campo della casa Magi “Masòn”, poi “Cremlino”. Al centro in azione di gioco con maglietta e pantaloni bianchi si riconosce Cino Ubalducci
Sul far del giorno erano risalite le avanguardie canadesi lungo il lieve pendio che dal torrente conduceva alle nostre case. I fanti affiancavano i carri armati e gli altri mezzi blindati. I tedeschi erano scappati lungo lo stradone pochi minuti prima, anzi uno di loro nella cucina di Teresa Benelli, la moglie di Secondo, fu fatto prigioniero in mutande, perché si era attardato per farsi rammendare i pantaloni ed attaccare i bottoni. Probabilmente lo aveva fatto apposta perché si era stancato della guerra.
Il luogo ove noi eravamo sfollati è la Levata, l’estrema punta verso levante del Comune di Saludecio a confine con San Giovanni e con Tavullia. Abitavamo da sfollati nel podere dei Morganti, signori di Roma, in casa della famiglia dei Piccari, loro contadini. Era una delle tre famiglie contadine del piccolo nucleo di sette case, le altre quattro famiglie erano di piccoli possidenti, tutti parenti tra loro e si chiamavano di cognome tutti Benelli infatti. Una Benelli Pasquina aveva sposato Adamo Bergnesi e la loro casa era di fronte a quella dei Piccari, adiacente a quella dei “Prèsa” che di cognome si chiamavano Bertuccini ed erano un’altra delle tre famiglie contadine. La terza famiglia colonica era quella dei Tomasetti, detti “Minghiten”, il cui padrone del podere era un certo Morbiducci.
Il piccolo ghetto di case era diviso da una strada in salita sulla cui sommità vi era il pozzo. Era questa una cisterna costruita aderente alla strada, che da questa raccoglieva l’acqua piovana e ne faceva un deposito. Quell’acqua serviva per bere e per cucinare. D’estate scarseggiava e diventava una densa brodaglia di fango che occorreva fare depositare nei recipienti prima di utilizzarla. Ovviamente non c’era l’acquedotto pubblico ma non c’era nemmeno la luce elettrica nella Levata.
Ricordo che mia madre, di tanto in tanto, esordiva: “Fat courag Silvio che san ciapen al tifo stan an al ciapen più”. Quella mattina, molto presto, mia madre con l’ “orcio” e la corda, si era recata ancora nottetempo al pozzo, per attingere un po’ d’acqua. Un soldato tedesco in ritirata l’aveva fermata per raccomandarle di stare chiusi in casa quel giorno. Era stato un insolito comportamento quello del tedesco, senza arroganza e senza prepotenza, come invece eravamo abituati nei rapporti con quegli occupanti.
Da poco erano ripresi gli spari e si sentivano qua e là delle raffiche. Nella casa dei Piccari, ove noi eravamo sfollati, il sabato mattina presto, si faceva abitualmente il pane. Era questa una usanza settimanale tramandata nel tempo e quel mattino gli uomini di casa avevano già acceso il forno e stavano preparando la creta per sigillare lo sportello di ferro che si metteva alla bocca del forno dopo aver introdotto il pane da cuocere. Le donne stavano allestendo le “asse” in cucina con i filoni di pane da introdurre per la cottura.
Il forno era di fuori e nella cucina si sistemavano i pani su queste “asse” da portare davanti alla bocca del forno. Ad un tratto arrivarono i primi soldati alleati, erano giovani canadesi con un elmetto del tutto diverso da quello dei tedeschi che eravamo abituati a vedere e che ci incuteva paura e terrore.
Entravano nelle case col fucile puntato, questi giovani appena arrivati, chiedendo se vi fossero ancora i tedeschi, poi visitavano tutte le stanze calciando l’uscio per sincerarsi. Poco dopo si era fatto giorno e la strada era gremita di soldati e di gente a festeggiare questi liberatori che da giorni aspettavamo con ansia e con speranza.
E’ difficile descrivere la contentezza e l’euforia che si vedevano dipinte sul volto delle persone. Sembrava che di botto fossimo piombati nel pieno di una festa paesana. Le donne di casa si precipitavano con i bicchieri e le brocche del vino e dell’acqua e con il pane appena cotto. I militari distribuivano le sigarette agli uomini e la cioccolata ai bambini ed in molti si abbracciavano anche se si vedevano per la prima volta.
Il viso dei miei genitori e specialmente quello di mio padre, che non era mai riuscito a nascondere la paura e l’angoscia, si era di nuovo aperto alla gioia ed alla speranza. Erano i nostri liberatori quei giovani che parlavano altre lingue.
Purtroppo uno di questi di lì a pochi minuti ed a poca distanza fu falciato da una granata tedesca e la camionetta che lo portava indietro ci mostrava tutto l’orrore che si consumava in quel povero corpo sanguinante e con le redini rotte.
Ci fu immediatamente imposto di sgomberare la strada e chiuderci nelle case o nei rifugi, giacché il pericolo non era affatto passato. Noi ci eravamo asserragliati nella stalla di casa nostra cioè dei Piccari e molte persone erano con noi confluite. La posizione di questa stalla permetteva infatti di vedere dai finestrini alti, con dei supporti sotto i piedi, ciò che succedeva nella strada.
Ad un soldato alleato armato di fucile era stato consegnato il prigioniero. Il canadese aveva mandato il tedesco lontano da sé con la schiena contro la parete della casa dei Bergnesi e con le mani alzate, poi aveva piegato una gamba appoggiando il ginocchio a terra per tenere il fucile puntato sull’uomo.
Durante questa scena l’unico “intellettuale” (*) degli sfollati, che era con noi nella stalla, ci assicurò che il canadese lo avrebbe ucciso. Io vedevo l’incredulità di mio padre e degli altri contadini: “ma l’è un prisugner, cum al po es cul maza?” “Io queste cose le capisco e so che sta per ucciderlo, io me ne intendo”.
Intanto il canadese, con l’altra mano toglieva lentamente il pacchetto delle sigarette dalla rete dell’elmetto, ne faceva uscire una, la metteva tra le labbra poi accendeva il fiammifero, poi riponeva il tutto nella rete. Gli alleati avevano infatti una rete che avvolgeva la parte esterna dell’elmo di ferro, sulle cui falde, tra queste e la rete stessa, stavano collocati i piccoli medicinali, le sigarette, la cioccolata, il chewing gum ed altri generi di sussistenza immediata. Noi li chiamavamo “gli inglesi”. Quelli che arrivarono da noi erano i canadesi della VIII Armata del Generale Alexander, più precisamente erano del 1° corpo d’armata del Generale Burn.
La morte purtroppo arrivò anche tra noi nella nostra piccola comunità di sfollati e di gente del posto. Era il pomeriggio di quel sabato ed il fronte di guerra aveva fatto solo qualche chilometro dopo di noi e si era attestato nella vallata successiva a quella che dalla fine dello stradone scendeva nel Comune di San Giovanni per risalire al crinale dirimpetto di Monte Lupo, di là vi era la vallata del Ventena. I tedeschi sparavano le cannonate verso di noi dalla direzione di San Marino ed una granata colpì la casa dei Galeazzi.
Alla distanza di poco più di cento metri da noi, dall’incrocio vicino al pozzo da cui partiva una stradicciola sassosa che scendeva nella “Carbonara”; vi era e vi è ancora, una vecchia casa colonica doppia abbinata per due famiglie contadine, una dei “Gagliaz” ed una dei “Curtel”, che era alla sinistra di chi percorreva quella stradina in discesa. Dall’altra parte della strada, nel campo, che declinava dolcemente verso valle, gli uomini del posto ed anche mio padre, avevano realizzato un ampio rifugio collettivo a ferro di cavallo. Le due entrate erano alle due estremità rivolte verso il basso. Per eseguirlo era stato praticato uno scavo largo poco meno di due metri e profondo altrettanto per uno sviluppo in lunghezza di circa 15 e più metri a forma di mezzo cerchio, anzi di una “C”. Per coprirlo erano state abbattute delle grosse piante per ricavare delle travi di copertura completate da rami grossi più le ramaglie, il fogliame ed un soprastante spessore di circa mezzo metro di terra di riporto.
Io non avevo ancora nove anni ma con gli altri ragazzi coetanei tutti abbiamo partecipato ai lavori. Nei giorni immediatamente prima dell’arrivo degli alleati, a partire dal mercoledì 30 agosto, un intenso cannoneggiamento alleato aveva bersagliato tutta la nostra zona ed un pomeriggio intero avevamo dovuto attardarci nel comune rifugio io, mio padre e la mia sorellina Adriana, che non aveva ancora quattro anni. Mia madre era rimasta in casa, aveva meno paura degli eventi ed anche del pericolo che la guerra rappresentava. Altre persone erano già uscite dal rifugio per raggiungere le case per la notte. Di solito di notte i cannoneggiamenti smettevano, mio padre si decise, prese in braccio mia sorella, uscì dal rifugio e di corsa, mi invitò a seguirlo. Si vedevano nel campo le buche ancora fumanti ad imbuto, ove poco prima erano scoppiate le granate, si udiva attorno ancora qualche scoppio e ad ogni esplosione ci si buttava a terra e poi si riprendeva.
Ricordo che si preferiva cercare il riparo in una di quelle buche fresche perché era opinione diffusa che mai avessero sparato due volte con la medesima altezza e direzione di tiro. Non ho mai saputo se la cosa fosse vera o no. Ricordo che in quella rocambolesca e affannosa corsa in salita, tra il sibilo delle granate ed i bagliori che provenivano dalla zona del Pesarese, ho perduto uno zoccolo e non l’ho più ritrovato.
Il pomeriggio di quel sabato due settembre, il rifugio era gremito di gente e quel giorno le cannonate arrivavano dalla direzione opposta tirate dai tedeschi. Si era fatto tardi ma la gente era restia ad uscire. Una delle due bimbe gemelle di quattro anni della Maria Fabbri (**), sfollata da Cattolica come noi, sentiva freddo e sua madre uscì dal rifugio per andare in casa al di là della strada a prendere una coperta. L’aveva già presa e dalla camera si accingeva ad uscire quando una cannonata colpì la spalla della finestra, poi scoppiò all’interno della stanza contro la parete laterale e le schegge frantumarono il muro, lo specchio ed il comò. La Maria era di fronte al comò, non aveva fatto in tempo ad uscire e prendere la scala. Un nutrito numero di schegge fumanti si erano conficcate nella sua schiena, dal collo alle gambe. Da quella casa fu trasportata distesa su un carro, in salita nel nostro ghetto, in casa di Salvatore Benelli detto “Tor”, marito della Gemma; che era di fronte a quella dei Bergnesi, allo stesso lato della strada.
Fu stesa a terra a pancia sotto, sopra delle coperte di fortuna nella stalla, alla tenue luce del lume a petrolio e per tutta la notte ivi restò bocconi, con altre 20 – 30 persone che eravamo ed il bestiame che era rimasto dopo la razzia dei tedeschi.
Mia madre si prodigò tagliando un lenzuolo bianco per farne delle bende da stenderle sulla schiena a protezione delle ferite. La poverina si lamentò per tutta la notte. Le schegge le avevano perforato parti vitali. Mia madre e le altre donne cercavano con ogni mezzo di alleviarle il dolore, ma non sapevano cosa poter fare. Gli uomini cercavano aiuto dai militari alleati.
Durante la notte fu rintracciata sua madre che era ancora in zona di guerra ed alla mattina seguente su una camionetta dei canadesi fu portata all’ospedale di Pesaro, passando per i campi. Sulla camionetta con lei e con il militare che la guidava salì sua madre e con loro fu adagiata anche la “Elvira ad Curtel”, una ragazzina di 13 anni che nello scoppio della granata rimase sepolta dalle macerie e non dava segno di riprendersi nemmeno il giorno dopo pur essendo ancora viva (***). Morì dopo quattro giorni, il 6 di settembre nell’Ospedale di Pesaro, ed aveva soltanto 24 anni la Maria Fabbri conosciuta come “la Maria sfuleda”.
Sua madre tornò a casa a piedi da Pesaro, alcuni giorni dopo, passando per i campi. Noi ragazzi la vedemmo risalire dal Tavollo lentamente lungo il pendio, a piedi scalzi e con le scarpe nelle mani, scartando le zolle ed inciampando, con gli occhi pieni di lacrime aggrumate; un fazzoletto nero attorno alla testa legato sotto il mento ed il corpo smilzo e rinsecchito che denotava una precoce vecchiaia; le membra penzoloni e lo sguardo impietrito: “La Maria la à morta, andò cli è li do bourdlègnie?”.
Il marito della Maria si chiama Bruno Leardini ed è un caro amico. Si era fatto tutta la guerra e quando, nel 1945 era tornato dalla prigionia, non capiva la perplessità e lo sgomento che vedeva dipinti sui volti di quanti incontrava per la strada del ritorno nel paese, prima di giungere a casa a Cattolica. Lui si aspettava una esplosione festosa, la gente lo guardava e non sapeva cosa dirgli.
(*) L’intellettuale, nella nostra stalla, era Morbiducci, il padrone del podere dei “Minghiten”.
(**) La Maria Fabbri veniva comunemente chiamata dalla nostra comunità della Levata “la Maria sfuleda” per distinguerla dalle altre e tante donne che si chiamavano Maria.
(***) La Elvira evidentemente aveva subito una commozione cerebrale che però non era stata di intensità irreparabile, vero è che due settimane dopo tornò a casa a piedi da sola dall’ospedale di Pesaro, attraverso i campi.