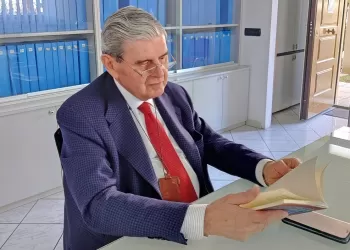– Era la primavera del 1943 ed io frequentavo la seconda classe elementare dalle suore. L’Istituto si chiamava come oggi, “delle Maestre Pie dell’Addolorata”.
Il portone d’ingresso era in cima alla salita -(la costa dli sor)- e la strada Via Pascoli che percorrevamo per arrivarci si chiamava allora, Via Principe di Napoli, davanti alle suore comincia la Via Carlo Cattaneo che allora si chiamava Via Umberto I.
Il portone delle suore, con l’ingresso alla scuola, era all’incirca di fronte al vecchio Palazzo Alessandrini, (demolito e ricostruito circa 37 anni fa dai f.lli Montanari di Morciano), ove, al pianterreno, c’era nell’angolo una vecchia osteria (detta della “Norina”) i cui avventori, nell’uscire di notte, orinavano abitualmente contro la mura della Rocca dei Verni, all’inizio della Via Aurelio Saffi.
Le pisciate contro il muro, una accanto all’altra, conferivano le forme di tante tipiche figure appuntite verso l’alto, il cui vertice era il punto più alto della spinta orinatoria. L’orina, data la pendenza delle due strade in quel punto, scendeva poi sul selciato scorrendo sull’acciottolato dei sanpietrini in un rigagnolo lungo la discesa.
A fianco dell’osteria, prima della bottega del vetraio, vi era il negozio di frutta dei “gagin”, ovvero dei fratelli Francolini.
Ma ritorniamo al fabbricato scolastico. Attraverso un ingresso, che a me incuteva un certo timore appena entravo, si accedeva ad un cortile interno tipo cavedio, circondato ai quattro lati interamente dal complesso scolastico e di abitazione delle suore.
A sinistra si scendeva nella chiesa ove quotidianamente ci portavano a pregare.
L’aula ove feci la prima elementare era ubicata sulla sinistra dell’ingresso, appena entrati e mi ricordo che una buona parte di quel primo anno fu impiegata a fare le aste.
In seconda elementare invece si cominciò già ad avere le nozioni di scrittura su quei quaderni con prestampate le righe alte e proporzionate alla classe elementare di appartenenza.
Mi ricordo che la nostra maestra di quell’anno, (forse Suor Ines?) era buona, con un carattere mite e comprensivo e mal si adatta a lei un mio triste ricordo per un episodio che indubbiamente ebbe per protagonista non lei, ma una maestra supplente.
Fu appunto nella primavera del ’43. Un bel giorno, anzi un brutto giorno o meglio un mattino, la maestra ci disse che al pomeriggio avremmo dovuto venire a scuola con la divisa perchè al Teatro Zacconi c’era il raduno delle autorità fasciste e le classi partecipavano in divisa con le proprie insegnanti.
Abitualmente noi maschi eravamo vestiti con i calzoni corti, qualche volta in pieno inverno i pantaloni erano alla zuava e sopra un abbondante grembiule nero abbottonato dietro con un colletto bianco inamidato che teneva serrato il collo. Sul braccio, oppure sul petto, sopra il grembiule nero, veniva cucito il numero romano della classe di appartenenza ricavato da una fettuccia bianca tagliata a piccole strisce.
Le femmine avevano invece un grembiule bianco sulla sottana. Le gambe nude con le calze basse o con i calzettoni di lana mostravano d’inverno non di rado, più che alle mani e più che alla punta del naso o degli orecchi, le doloranti ulcerazioni, dovute ai geloni, con piccole chiazze rosso-bluastre.
Quel pomeriggio si doveva tornare a scuola in divisa perché c’era un’importante manifestazione del regime.
Noi maschi a quell’età eravamo i “Figli della Lupa”, i più grandi invece erano i “Balilla” e li si guardava con una certa ammirazione.
Proviamo a pensare che tipo di fascino poteva esercitare in un bambino tutto l’armamentario della vestizione con la divisa.
Occorreva la camicia nera che era di regola di un tessuto lucido e pesante, poi le bandoliere bianche che si incrociavano sul petto ove veniva apposta una fibbia a forma di “M”, che voleva dire Mussolini; i calzoni corti color grigio-verde, i calzettoni pure grigioverdi di grossa lana ed in testa il Fez nero con il pon-pon che ciondolava da una parte.
Io la divisa non l’avevo, a casa mia mancava non solo il denaro per acquistarla, ma anche la disposizione di animo per la divisa. Mio padre era un antifascista ed a me lo diceva. Si fidava, anche se ero piccolo, sapeva che non avrei raccontato fuori di casa ciò che mi insegnava.
Ricordo però che mi sarebbe piaciuto averla, quella divisa, per fare la mia bella figura. Avevo sette anni e mezzo, in quella primavera del 1943.
Quando capitavano questi raduni mia madre andava dalla Enrica Baffoni, (una vicina che abitava in Via Bologna, poco lontano da casa nostra in Via Brescia), a chiederla in prestito, il cui figlio, di due anni più grande di me, aveva poco più della mia corporatura.
Quel giorno però, il raduno nel Zacconi aveva un carattere generalizzato e tutte le classi dovevano essere presenti, quindi la divisa di Americo Baffoni, il figlio della Enrica, serviva a lui e non potè darla in prestito.
Io, a malincuore, mi recai ugualmente a scuola e, con spirito di iniziativa, cercai comunque di assestarmi alla meglio nel mio vestiario con un po’ di inventiva.
I pantaloni corti erano grigio scuro e si assomigliavano abbastanza bene, a parer mio, a quelli della divisa. Il grembiule nero, anzichè di fuori dei calzoni e penzoloni fino alle ginocchia come si portava sempre, ve lo infilai all’interno dei pantaloni, stringendovi la cinghia sopra in modo da farlo sembrare una camicia. Non avevo il resto della bardatura ma mi misi ugualmente in fila nel mio posto, che era il penultimo, giacchè questa partiva dai più piccoli ed era crescente in rapporto all’altezza ed io ero tra i più alti.
La maestra era al cancello aperto e, già contrariata per il numero degli assenti, ci faceva uscire in fila indiana osservandoci.
Il grande cancello di ferro sul retro del cortile, che immetteva nella piazza del mercato era all’incirca nello stesso luogo ove è ora. All’interno vi era un ampio spazio cortilizio perimetrato su tre lati dalle costruzioni. Il quarto lato lasciava la visione aperta verso nord-ovest ed al margine del cortile vi era l’orto ove una suora anziana coltivava abitualmente il terreno.
“Att-tenti” – “avanti”.- “marc” erano gli ordini precisi della suora e noi, alzando le ginocchia e alternando avanti ed indietro le braccia, si usciva marciando, busto eretto, sguardo in avanti, così come ci insegnavano, perchè la classe doveva fare buona figura.
Quando arrivai sulla soglia del cancello la maestra mi squadrò con uno sguardo stupito ed anche irritato e poi mi allungò uno schiaffo e mi lasciò lì, nel cortile. Non si era accorta prima che ero senza divisa, ma solo al momento del passaggio di fronte a lei.
Ricordo che piansi più per la umiliazione che per il dolore e, rimasto in disparte, vidi poi richiudersi il cancello dopo la sortita di tutte le classi. Ricordo che, accovacciato contro il muro del fabbricato, feci tutto addosso. Un tiepido sole scaldava a malapena quella parete e nel cortile non c’era rimasto nessuno, tranne la suora giardiniera che, al margine dello stesso, all’estremo bordo dell’orto, con in mano gli attrezzi agricoli era intenta a dissodare la terra. Qualche uccelletto azzardava timidamente avventurarsi dietro di lei per raspare con le zampette e beccare dove era stata rimosso il terreno.
Era una donna piccola e grassa, quella vecchia suora, con dei sottanoni neri, unti e bisunti e sporchi di terriccio. Mi venne a consolare con un buffetto in fronte, mi fece lavare, mi asciugò, mi diede un biscotto e mi fece stare con lei nell’orto per tutta la durata del raduno. Dopo più di un’ora, il cancello si riaprì, rientrarono le classi vociando e i compagni, con la innocente cattiveria che è tipica di quella età ingenua, mi portarono saltellando la sgradita notizia che per il giorno dopo si doveva fare il pensierino sulla adunata al Teatro Zacconi.
Ricordi scolastici: 1942-1943
Please login to join discussion