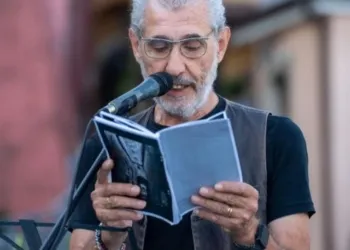– Io non sono mai stato tipo da aver paura, neanche se avessi incontrato il diavolo. Non avevo paura nemmeno degli apparecchi, perché non ci potevo far nulla, neppure quando a Rimini portavo i viveri a Venturi e mi capitava di imbattermi in un bombardamento. Le fortezze volanti venivano quasi tutti i giorni e le bombe cadevano a caso, poi per strada trovavi sparse le budella della povera gente. Se mi fosse cascata una bomba addosso, era destino. Sarei morto e zitti. L’unico pensiero era la convinzione che, per l’opera che stavo compiendo, almeno sarei andato in paradiso.
Fu però in questo secondo rifugio a Serravalle, con Max, che me la passai brutta come mai fino a quel momento. Fu quella la vera paura.
Ricordo che eravamo tutti prostrati dalla stanchezza. Il giorno che mio babbo seppe dei tre impiccati a Rimini, portandogli da mangiare ne parlò a Max, ma, in quel poco che potevano capire l’uno dell’altro, l’americano comprese che io fossi uno dei tre morti e si mise a dire che era meglio che smettessero di aiutarlo, perché, se io ero morto, allora anche lui si sarebbe ammazzato con un colpo di pistola. Per Max continuava ad essere sempre più difficile, così costretto com’era a non uscire mai dal rifugio in cui lo tenevamo nascosto. Mio babbo allora cercò di fargli coraggio e quando ci videro, a me e a Mario Ricci, comparire da lontano, Max corse fuori dal rifugio per raggiungerci e mi abbracciò stringendomi forte, con le lacrime agli occhi, per una decina di minuti.
Sempre qui, pochi giorni dopo, ce la passammo brutta come mai prima d’allora. Era mezzogiorno ed eravamo entrambi proprio all’imbocco della grotta: in quell’istante lui era appena entrato ed io quasi. Mezzo minuto prima eravamo a parti invertite: lui fuori ed io dentro, stavamo scavando nella terra con un pugnale. Mentre cercavo nella giacca il fazzoletto per asciugarmi la fronte dal sudore, dall’alto del dirupo sotto al quale eravamo comparvero improvvisamente due ufficiali tedeschi, urlandomi: “Cosa fare lì?” Se avessero scoperto anche Max, ci avrebbero fatto fuori tutti e due. E per terra, in vista, c’erano due pistole e due bombe a mano.
Io rimasi di sasso, non sapevo cosa rispondere, un pò mugolavo e un pò gesticolavo, come un infelice, mostrando la lunga ferita che avevo sulla coscia. E fu solo per pura fortuna, senza che neanche me ne accorgessi, che la giacca, cadendomi dalle mani, andò a coprire le armi. Poi, mentre i due tedeschi scendevano verso di noi, presi il mio bastone e zoppicando andai loro incontro. Loro annuirono, “Ja! Ja!”, come se, messo come ero messo, non fossi più degno della loro attenzione e poi comparve anche il resto dei soldati, saranno stati una cinquantina, che si misero tutti ad abbeverare i loro muli nel laghetto proprio di fianco all’ingresso della grotta. Allora nascosi le armi in una buca e, per tenerlo nascosto, feci scivolare Max nello stesso laghetto in cui bivaccavano i muli, ma sul lato opposto, quello coperto dai rovi in cui era più difficile accorgersi della sua presenza. Poi, in qualche modo, sempre zoppicando col mio bastone, assieme ai soldati mi misi a mangiare l’uva matura di una pergola lì vicino.
Ad un certo momento mi feci da parte e chiesi alla contadina della pergola, di lì a qualche ora, di scendere verso il laghetto come se niente fosse, a raccogliere i radicchi, e di chiamare Max, facendo attenzione che nessuno fosse vicino, ma proprio nessuno. Lei lo fece, una prima volta, senza avere alcuna risposta. Allora le chiesi di tornare una seconda volta, ma di riprovare tra le viti, sperando che Max potesse essersi rifugiato lì nel frattempo, e poi una terza volta ancora più in alto, tra le querce, temendo che i tedeschi ne avessero scelta una per impiccarlo. Anche qui nessuno rispose.
Fu solo quando potei scendere io, alle quattro del pomeriggio, dopo che i tedeschi se ne erano andati, che Max emerse fradicio dai rovi del laghetto e mi strinse forte, piangendo, ed io con lui che mi diceva di non lasciarlo mai più, fermi e appesi l’uno all’altro quasi mezz’ora.
Allora partimmo per un altro rifugio, verso la Torraccia, in un’altra parte del territorio di San Marino, dove già era nascosta la mia famiglia. Il fronte si faceva sempre più vicino e noi, lì, gli ci facevamo ancora più vicini. Ricordo che con noi avevamo un tino pieno di vino. Pesava così tanto che lo reggevamo in due, da un lato e dall’altro, ma, quando arrivammo sul lato della conca su cui era più facile che cadessero le granate, allora lo abbandonammo per affrettarci. Ero convinto che l’indomani sarei tornato a riprenderlo.
Alla Torraccia c’era un capannone di legno in cui erano custoditi tanti cavalli tedeschi, uno più bello dell’altro. E ci eravamo appena fermati lì, per una sosta, quando cominciò un bombardamento terribile. Come se all’improvviso fosse arrivato un fiume di granate. C’erano tuoni e sibili, di continuo. Cercammo quindi di affrettarci ancora più veloci verso il nostro rifugio. Era sull’altro lato della conca, verso le linee da cui sparavano gli alleati. E per la strada incrociavamo i soldati tedeschi in ritirata. Indietreggiavano, urlando, tutti insanguinati. Per loro era come se noi, vestiti da civili, non esistessimo. Finché arrivammo al rifugio: io ero con la mia famiglia, Max in un altro quaranta metri più in là. Entrambi venivamo sorvolati dal tiro dei cannoni alleati, che partiva dalla sommità della collina ed arrivava a segno davanti ai nostri occhi sull’altra collina. E qui restammo una decina di giorni, in mezzo al fronte, proprio nella terra di nessuno, e davanti a noi vedevamo tutti i combattimenti. Era una carneficina. Da un lato salivano una quindicina di soldati alleati (quasi tutti dalla pelle bruna, color creta), stringendo la bandiera inglese che io vedevo per la prima volta nella mia vita, e i tedeschi con la mitragliatrice li falciavano sul posto. Poi di seguito arrivavano due soldati con le barelle, con la croce rossa avanti e dietro sulla divisa, a raccogliere quei poveretti tutti sbudellati. E questa scena si ripeteva continuamente: davanti ai nostri occhi vedevamo che, gruppetto dopo gruppetto, li mandavano tutti a morire. Una cosa orribile, da assassini. E, a seconda di dove partivano le pallottole tedesche, gli inglesi orientavano il tiro dei loro cannoni e le schegge delle loro granate facevano il resto, schizzando come coltelli in tutte le direzioni. Si vedevano morti ovunque e tutto veniva spianato dai colpi.
Quando la battaglia terminò, io mi presentai assieme a Max alle truppe inglesi. Un ufficiale gli chiese con sarcasmo se tutto quel tempo era stato bene coi partigiani, al riparo dalle battaglie (anche perché tra inglesi e americani non correva buon sangue), ma Max fece un ghigno e ci passò sopra. Era troppo commosso per darci peso, era salvo. Poi ci portarono entrambi in una cantina a Vallecchio. A dormire lì, dopo tutti quei giorni sottoterra, mi sembrava di essere sul più soffice dei materassi. Gli inglesi volevano che all’indomani avanzassi con loro, a scoprire dove fosse l’artiglieria tedesca, ma io volevo tornare dalla mia famiglia e a casa, così accompagnai Max fino alle forze a Morciano e quindi ci separammo definitivamente.
Fu l’ultima volta che ci vedemmo, ma non perdemmo i contatti. Dopo la guerra, la prima cosa che mi spedì dall’America furono due chili di sale. Era un modo per non dimenticarsi di tutte le volte in cui avevamo preso la carne dalle bestie uccise dalle granate, provando poi invano ad ammorbidirla nell’acqua. Era immangiabile, serviva il sale che non avevamo, ma la mangiavamo ugualmente, perché serviva comunque a toglierci la fame.
Poi, per diversi anni, continuai a ricevere lettere e foto da Indianapolis, in cui mi raccontava della sua vita: lui, sua moglie, suo figlio, i suoi genitori, quello a cui era riuscito a tornare.
[b]Olmeda -[/b]
[i] E’ nato a Spontricciolo, quando era ancora comune di Rimini, il 7 maggio 1922.
Figlio e nipote di fabbri, cresce tra la bottega e le colonie dove vende souvenir a bambini e soldati in convalescenza.
Di fede comunista, come tutta la sua famiglia, durante la guerra svolge attività di propaganda contro il regime fascista e partecipa a numerose azioni partigiane. Inoltre, per 125 giorni nasconde e protegge Max Johnston, un aviere di Indianapolis, precipitato con i suoi compagni nella zona di Mulazzano. Nel dopoguerra, riprende su più larga scala la sua attività precedente e riesce a costruire un proprio albergo, tuttora gestito dalla figlia.[/i]