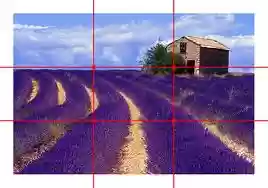di ALBERTO BIONDI
Di Nino Pedretti non avevo mai sentito parlare. Qualcuno della vecchia guardia, forse, ricorderà di aver letto il suo nome in una raccolta di poesie dialettali, magari accanto a quello di Tonino Guerra, Raffaello Baldini, Gianni Fucci. Per un pugno di santarcangiolesi, il nome di Pedretti significa ancora un viso una voce ben distinti; perché Nino è stato il poeta della porta accanto, quello che fino a pochi anni fa potevi incrociare in bicicletta o al bar, per strada o in bottega, prima che la malattia decidesse di portarselo via a soli cinquantasette anni, nell’81. Per chi è nato dopo o per chi non ha avuto occasione di conoscerlo di persona, c’è ancora la possibilità di “incontrare” questo grande della letteratura attraverso le parole che ci ha lasciato, parole di una rara bellezza, immeritatamente dimenticate. Grammatiche (Raffaelli Editore, 137 pagg. 15 euro) è una piccola raccolta di ventisette monologhi e racconti brevi, provenienti per la maggior parte dall’Archivio Pedretti della Biblioteca Comunale “A. Baldini” di Santarcangelo. Quando ho sfogliato il libro per la prima volta, ho subito pensato che in così poche pagine potesse starci solo una raccolta di poesie o un’opera teatrale, e in fondo non mi sbagliavo: Grammatiche, pur essendo in prosa, raccoglie brani dalla musicalità e ritmo quasi poetici, mentre il carattere dei monologhi, l’alternarsi dei personaggi, delle atmosfere, delle suggestioni non possono che richiamare un palcoscenico davanti al quale a sedere è il lettore.
Citando le parole di Nino: “Chi scrive in prosa non vede il mondo per punti, come in poesia. Lo vede per itinerari” si capisce come il concetto di scrittura proprio dell’autore si radichi in un senso di mobilità, di progressione continua, che ci porta a compiere un vero e proprio viaggio nella mente delle sue creature.
Così il primo a prendere la parola è un portinaio: “Ogni giorno come dal finestrino di un treno, io vedo passare persone diverse, così diverse che pare impossibile che stiano sotto lo stesso tetto. Ed anche forestieri. Io capisco da chi può andare un forestiero. A volte mi dico: questo va dal Manzi, questo va dal colonnello, quest’altro invece dal ragiunat. E spesso non mi sbaglio. Ed è questo di più che metto nel mestiere che lo rende bello, non dico ai miei occhi, ma al mio senso dell’immaginazione”. E poi c’è quello che vive degli affari altrui, il furbo, il bottegaio, il professore morto di fame che confessa: “Io sono un ammalato cronico di mancanza di denaro e mio malgrado ho preso ad avere un’occhiata adunca verso il denaro, simile a quella dei bottegai, di cui tuttavia non ho l’animo volgare e sciatto. Io ho letto Platone in greco, non lo dimenticate. E Platone dentro di me rugge e ha le convulsioni. E si lamentano anche Petrarca e l’Ariosto. Il Tasso poi, come potete immaginare, è disperato”.
Pedretti scrive avvalendosi di un’ironia sottile, dal sapore pirandelliano, di certo influenzato dalla lettura dei russi (Dostoevskij in primis, di cui si avverte l’eco all’inizio di ogni monologo). Lo stile è limpido. L’aggettivazione, dietro l’apparente semplicità, parca e studiatissima. Come filo sotteso tra un capitolo e l’altro c’è una visione tragica e fatalista della vita, pur comunque smorzata all’interno degli affanni quotidiani che hanno il potere straordinario di rendere tutto meno serio, più controllabile e tollerabile. Dietro alla scrittura di Pedretti si intravedono gli accenni di un suo personale sistema filosofico, esplicitato dalle parole di una suora che si domanda: “Ecco, io non capisco. Capisco la realtà del dolore, la sento, ma non afferro la sua necessità. Perchè, perchè? Ho allora concluso che è una condizione. É la condizione della nostra vita, come il cerchio è tondo o l’aria azzurra. E la gioia è fatta di piccoli spazi, fori, dove noi non possiamo stare che poco, un nulla o quasi”.
Niente per Pedretti sfugge al suo destino, alla sua fine, nemmeno l’amore, quando scrive: “Ecco, disse lui: questa sarebbe stata la nostra vita. Perchè dici sarebbe stata la nostra vita? disse lei che non aveva capito di trovarsi in un sogno. Hai ragione, concluse lui, è la nostra vita, ma non possiamo condividerla. Neanche se ci vogliamo bene? disse lei. Neppure se ci vogliamo bene perché l’amore è una trasversale che taglia l’impossibile solo quando le cose della realtà quotidiana sono possibili. Allora l’amore non è grande cosa, disse lei. Tu mi hai abbandonato, disse lui, non perché sei malvagia, ma perché l’amore non è sufficiente. Non si ama infatti con l’amore, ma si ama con l’assurdo e questo vale per la vita e per la religione”.
“Grammatiche”, il titolo della raccolta, può significare molte cose. Nino Pedretti fu anche linguista e traduttore, visse per alcuni periodi della sua vita in Germania e qui ebbe modo di contrarre la passione (tipicamente tedesca) per la filologia. Da alcune sue lettere possiamo intuire che il significato di “Grammatiche” vada ricercato in un “paradigma” di personaggi che, alla stregua di un sistema ordinato di segni linguistici, può esistere solo grazie a strutture profonde che ne stanno alla base. Grammatiche dell’Essere, in una certa misura, utili a rivelare tutta l’infinita e abissale complessità del nostro io. Leggendo questa raccolta è inevitabile associare alle creature pedrettiane un volto noto, un conoscente, un personaggio di quartiere o un parente. Come ha scritto Carlo Bo: “Pedretti è uno dei rari poeti per necessità in un tempo ricco di poeti per convenienza o per casuale coincidenza”.
Il 2013 segna il novantennale esatto dalla nascita di Nino Pedretti. Sarebbe un vero peccato non cogliere l’occasione per leggere e ri-leggere gli scritti di questo grande non della letteratura locale, ma oseremo dire nazionale, perché se c’è morte peggiore per uno scrittore è quella a cui vanno incontro le sue parole, soprattutto se hanno ancora il potere di dirci qualcosa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA