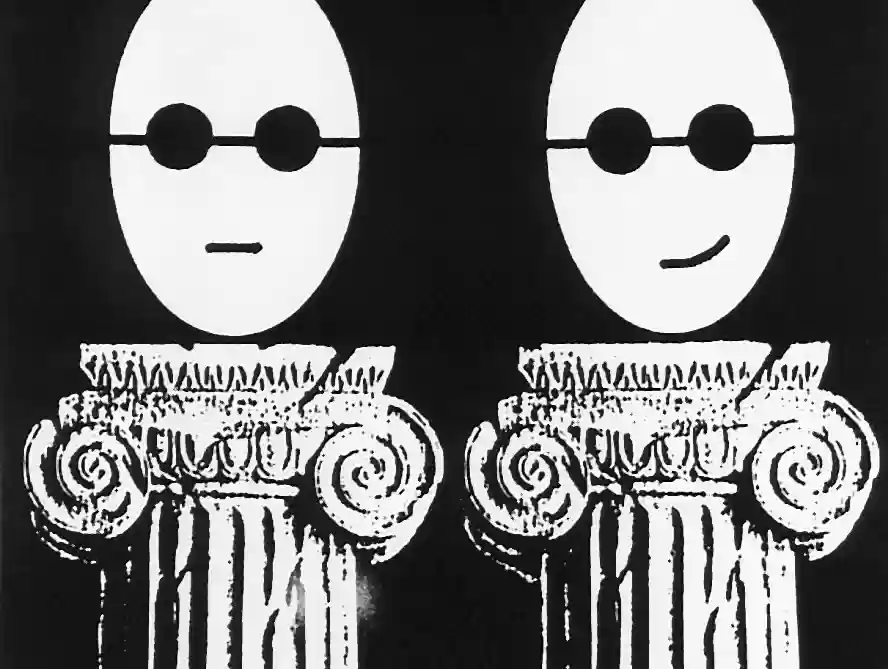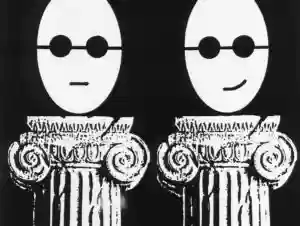
Tratto da lavoce.info
di Pietro Ichino, professore alla Statale di Milano
Un emendamento in discussione alla Camera rischia di fare della possibilità di lavorare da casa un privilegio per una parte dei dipendenti pubblici, senza l’indispensabile ammodernamento delle amministrazioni sul piano tecnico, organizzativo e culturale.
Un po’ di piombo nelle ali del lavoro agile
Il lavoro “agile” (detto anche smart working) è tale perché si è liberato dai vincoli che tradizionalmente caratterizzano il lavoro dipendente: vincoli di orario, di spazio dove la prestazione deve svolgersi, di burocrazia aziendale. È “agile”, o “smart”, perché funziona sulla base di un rapporto di fiducia e collaborazione tra le parti particolarmente intenso, che sostituisce timbratura del cartellino e altri controlli sull’assiduità dell’impegno.
Così inteso, costituisce una risorsa preziosa per il miglioramento delle nostre vite e della nostra economia, per la riduzione dell’inquinamento ambientale e anche dei costi aziendali. Ed è condivisibilissima la speranza diffusa che lo shock della pandemia favorisca una rapida diffusione di questa nuova forma di organizzazione del lavoro.
Ora, però, tutta la sua “agilità” rischia di perdersi se viene fagocitata dal business della burocrazia giuslavoristica, incominciando così a essere appesantita da regole, verbalizzazioni, scartoffie e ricorsi. Nel linguaggio tecnico si chiama “giuridificazione”.
A ben vedere, il processo è già cominciato con la legge n. 81 del 2017, che ha avuto, sì, il merito di riconoscere il diritto di cittadinanza del “lavoro agile”, ma ha avuto anche il demerito di introdurre qualche primo elemento di burocrazia che sarebbe stato meglio evitare.
Il modo sbagliato e quello giusto di promuovere il lavoro agile
Il rischio è che il processo di giuridificazione prosegua con il consolidarsi per legge di un “diritto al lavoro agile” che è già stato introdotto per decreto in riferimento all’emergenza sanitaria, sia per il settore pubblico sia per quello privato. Se da emergenziale diventasse stabile, la disposizione comporterebbe l’onere permanente per il management aziendale di verbalizzare i motivi del rifiuto opposto alla richiesta di qualsiasi dipendente di poter lavorare da casa. Anche chi è incaricato di mansioni che non possono svolgersi in alcun modo “da remoto” – come quelle di un addetto alla reception, di un bidello, di un custode di museo, di un magazziniere – potrebbe rivendicare lo spostamento a mansioni compatibili. E i motivi dell’eventuale rifiuto diventerebbero a quel punto un possibile oggetto di impugnazione e quindi verifica in sede giudiziale, col risultato di sostituire il giudice del lavoro all’imprenditore in questo aspetto della gestione aziendale.
Il contenzioso giudiziale ha già incominciato a fiorire sulla base dei decreti emergenziali, e già si hanno le prime sentenze che condannano aziende pubbliche e private a consentire il lavoro da casa su prescrizione del medico (così i tribunali di Bologna, Roma e Grosseto).
Uno smart work promosso in questo modo non ha evidentemente più niente di smart: nasce con un imprinting contenzioso, quindi senza alcun rapporto di fiducia tra le parti, come una sorta di esonero parziale per persone che hanno dei problemi, invece che come evoluzione organizzativa guidata dalle persone più motivate e professionalmente attrezzate. Se lo vogliamo promuovere davvero, non dobbiamo puntare sulle carte bollate, ma sugli incentivi ai servizi necessari per la sua diffusione. Tra questi, in primo luogo, la proliferazione capillare di luoghi adatti al lavoro agile, a disposizione di tutti coloro – e sono la maggioranza – che non hanno nella propria abitazione un locale adatto per svolgervi la propria attività professionale, ma che sarebbero fortemente interessati ad averne uno nei pressi, il cui costo sia a carico dell’azienda.
Una norma pericolosa in discussione in Parlamento
Nei giorni scorsi la Commissione bilancio della Camera ha approvato, riformulandolo, un emendamento di Vittoria Baldino, che obbliga le amministrazioni pubbliche a programmare il lavoro agile almeno per il 50 per cento “delle attività che possono essere svolte con questa modalità” entro la fine di quest’anno, per il 60 per cento in seguito. Non più, dunque, lo smart work che nasce dalla verifica sul campo della propria utilità e fattibilità, favorito dalla qualità delle persone interessate e dalla capacità della struttura aziendale di ripensarsi e attrezzarsi sul piano tecnico, organizzativo e culturale, bensì un beneficio – per non dire privilegio – attribuito burocraticamente a una percentuale predeterminata del personale. Non la possibilità del lavoro da remoto dimostrata sul campo dalle persone più capaci di responsabilizzarsi per il conseguimento di obiettivi precisi, ma il diritto a non recarsi in ufficio conquistato attraverso graduatorie costruite sul numero di figli piccoli o di parenti disabili a carico, quando non su certificazioni dei medici curanti.
La quota del 50 per cento indicata nell’emendamento riecheggia una decisione preannunciata dalla ministra della Funzione pubblica al quotidiano La Repubblica il 26 giugno scorso: “Entro fine anno abbiamo intenzione di censire le attività che si possono svolgere da remoto. Puntiamo al 50 per cento”. Dichiarazione, peraltro, non facilmente conciliabile con quella della stessa ministra del 17 giugno, di essere “orgogliosa del 90 per cento di dipendenti statali impegnati in smart working durante la pandemia”, addirittura con un aumento di produttività. Sta di fatto, comunque, che secondo una valutazione ben argomentata (Luigi Olivieri su Phastidio.net, 23 giugno) in realtà non più del 10 per cento delle funzioni svolte dai 3,2 milioni di dipendenti delle amministrazioni pubbliche è suscettibile di essere eseguita “da remoto”: percentuale, questa, che costituisce una media tra valori assai disuguali di amministrazioni con caratteristiche molto diverse tra loro. E anche quel 10 per cento richiederebbe un livello di modernizzazione, sul piano delle attrezzature e della cultura, dal quale le nostre amministrazioni pubbliche sono per lo più ancora molto lontane.
L’impressione è che nell’approvare l’emendamento Baldino, la Commissione bilancio della Camera non avesse le idee chiare su ciò che lo smart work è e su ciò che è davvero necessario per promuoverne lo sviluppo.