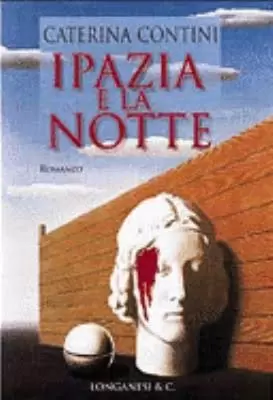di Silvio Di Giovanni
Cirillo era cresciuto sotto la guida di suo zio Teofilo di Alessandria ed assieme a lui, nel 403, aveva assiduamente partecipato al Sinodo della Quercia e alla deposizione di Giovanni Crisostomo, esiliandolo anche e, nove anni dopo, assurgendo al seggio episcopale di Alessandria con tutta la spregiudicatezza e violenza nella trattazione teologica contro i rivali di Antiochia e con l’emergente sede patriarcale di Costantinopoli.
Dotato di conoscenza della sua materia dottrinale e di volontà di potere, esercitò senza scrupoli ogni azione di violenza con incitazione alla piazza, facendo leva sul fanatismo degli ambienti monastici, fino a portarli al delitto contro gli avversari, in un clima di imperante intolleranza che fu sempre tipico del suo carattere.
In quel tempo viveva ad Alessandria la filosofa astronoma e matematica Ipazia, nata nell’anno 370, figlia del matematico Teone, dopo avere completato gli studi ad Atene, era tornata ad Alessandria, ove aveva aperto una scuola.
Le sue lezioni erano molto frequentate e riscuotevano l’interesse degli allievi per la capacità di eloquenza e sapere che emanava dalla sua cattedra.
Il suo insegnamento era basato sulla razionalità delle cose e sul rispetto delle persone e del diritto, indipendentemente dalle tematiche religiose e dalle intemperanti lotte intestine tra i cultori del sorgente cristianesimo, che si scontravano con reciproche accuse di eresie, condanne, sinodi e comportamenti violenti e denunciandosi a vicenda nel nome di Dio.
Ovviamente, questo intollerante nuovo modo di espressione degli esponenti religiosi con convivenza irrispettosa verso gli altri, era tanto più pesantemente usato nei confronti delle persone di cultura, che, nella loro morale di vita, erano estranee agli intendimenti religiosi.
Il vescovo Cirillo aveva in Alessandria delle bande armate di suoi fedelissimi, detti “parabolani”, molto ben addestrati, che di notte sciamavano per le vie di Alessandria, nel quartiere ebraico, danneggiando e distruggendo i negozi ed i banchi del commercio, dando fuoco a qualche abitazione, aggredendo gli abitanti nel sonno e mettendoli in fuga, atterriti.
E’ con molta fatica che il prefetto di Alessandria, con le sue guardie, riusciva a contenere queste incursioni, anche favorite dalla baldanza del vescovo Cirillo che, presso la corte di Costantinopoli, godeva di un certo favore. Questo vescovo sapeva usare l’occasione della morte di un certo Thaumasios, dichiarandolo beato, le cui gocce di un liquido miracoloso, che sarebbe il suo sangue, apportavano grandi benefici ai numerosi fedeli imploranti che, previo offerte, potevano godere di sicuri miracoli, anche a beneficio della Chiesa di Cirillo, facendolo diventare il più famoso vescovo dell’Impero d’Oriente.
Allo scopo, il vescovo Cirillo aveva fortemente indotto i propri seguaci, avvertendo loro che quello era un mondo di peccato e che contro il peccato si deve lottare. “Il peccato deve essere distrutto e così i peccatori, prima ridotti all’impotenza e poi distrutti”.
Il mondo doveva essere purificato dal suo male che si portava dietro fin dal tempo di Adamo. “Purificato nel fuoco e nel sangue”.
La filosofa Ipazia si era momentaneamente ritirata in campagna, in quella lunga estate africana, fuori dal suo museo e dalla sua Alessandria, e si stava occupando della stesura del commento a “Le Coniche” di Apollonio di Perga, su cui rifletteva da tanto tempo e discuteva con gli allievi del museo. Stava infatti coltivando l’idea di una sua concezione sull’opportunità di separare la matematica dalla geometria, onde aprire un discorso di potenze superiori non rappresentabili in senso spaziale.
Tra i suoi colleghi matematici, che pure la stimano tanto, non vi era condivisione in relazione alle sue nuovissime idee sulla possibilità di grande e futuro cammino nello sviluppo della matematica, ben oltre alla terza potenza.
Ipazia si è accorta che legare la geometria con la matematica è un errore in quanto quest’ultima ha davanti un possibile ardito e nuovo cammino di indagine delle scienze matematiche.
In questo suo approfondimento dello studio scientifico della matematica pura, in quel ritiro in campagna, si accorgeva di avere anche trovato il modo di alleggerire i suoi pesanti pensieri sui problemi di ogni giorno in Alessandria con le lotte e i tumulti cittadini dei cristiani contro i pagani, degli intrighi politici, del precario ordine cittadino e delle violenze che venivano perpetrate.
Uno dei migliori allievi di Ipazia era Sinesio di Cirene, filosofo neoplatonico di grande passione ed impegno, che poi, a causa degli eventi, finirà per accettare la cattedra vescovile di Tolemaide con non troppa convinzione e si troverà su un terreno di scontro ideale con gli insegnamenti della sua maestra, con la quale si riconcilierà in un pentimento di morte, colpito da una malattia, nel 413.
Poiché in Alessandria da tempo vigeva un deplorevole e scorretto comportamento di una parte della popolazione, Oreste, il prefetto, convocò un’assemblea di cittadini per tenere un discorso e decidere, mediante voto, le direttive da adottare per riportare la normalità.
Ma già la data di un sabato per la convocazione dell’assemblea provocò proteste da parte degli elleni che non gradivano la presenza degli ebrei e dei cristiani ed è così che, durante l’assemblea, nella piazza principale, si alzarono le prime grida da parte dei cristiani contro gli ebrei, tutti presenti nell’assemblea dando luogo i primi tafferugli al cospetto del prefetto, da cui le guardie prefettizie si vedono costrette ad intervenire.
Tra i cristiani che sono stati ben caricati dal vescovo Cirillo, vi è un certo Jerace, già più volte denunciato e fermato per violenze, che è il più facinoroso e violento del gruppo dei cristiani, e viene arrestato e punito sulla pubblica piazza con frustate onde mostrare alle genti quale ammonimento a tutti coloro che vogliono sovvertire l’ordine e infrangere le pubbliche leggi.
Questa punizione pubblica caricò il vescovo Cirillo di rabbia e lo mandò su tutte le furie.
Mandò a chiamare i capifamiglia degli ebrei ed in un incontro con essi, li affrontò volgarmente attribuendo loro le responsabilità di quanto successo e li insultò additandoli come deicidi, cioè responsabili della morte di Gesù e quindi popolo dannato da Dio, non popolo eletto da Dio. “….Vi schiaccerò come si schiaccia un insetto molesto” … “per cancellarvi dalla faccia della terra”.
A loro volta, gli ebrei si organizzarono per contrastare la violenza dei cristiani, ripromettendosi di reagire alla violenza con la violenza.
Il prefetto Oreste vorrà riunire il consiglio prefettizio ed illustrare lo stato di disordine che i cristiani e gli ebrei stavano provocando in Alessandria, al quale le poche guardie prefettizie, in numero insufficiente di fronte a bande infuriate della popolazione, non erano in grado di porre fine. Non era neanche il caso di chiedere rinforzi all’imperatore perché, questi, avrebbe messo nuove tasse per pagare le milizie, la qual cosa avrebbe provocato nuovi aggiuntivi disordini.
Il vescovo Cirillo pensò bene di incaricare una numerosa banda di monaci del deserto, detti “parabolani”, che erano noti per la loro crudeltà e violenza negli scontri ed erano nella loro vita addetti alla meditazione e contemplazione di Dio, mangiando poco, quindi sempre disponibili a qualsiasi azione, se il vescovo glielo ordinava. In città venivano solo quando si trattava di colpire e lo facevano con forza, precisione e velocità. Erano infatti leggendari per le loro imprese di guerra ed anche per la loro ferocia.
Il prefetto Oreste gira per la città, con la sua piccola scorta armata, per controllare che tutto scorra nella normalità e senza disordini, e non si accorge che un manipolo di uomini incappucciati, avvolti in un nero mantello ed armati, gli si sta avvicinando con scaltrezza e rapidità.
In un attimo, sette od otto di questi (che sono appunto i monaci parabolani), sono addosso al prefetto e con le grida insultanti di “Idolatra, pagano, empio, ti faremo pagare cara la tua presunzione, perché Dio è con noi”, iniziano a percuotere il prefetto in tutte le parti del corpo, ed uno di questi monaci di nome Ammonio, armato di una pietra aguzza, già preparata allo scopo, colpisce ripetutamente il prefetto al volto e alla nuca. Le poche grida di aiuto sono disperse ed alcune guardie fuggono vilmente, mentre dei cittadini presenti vedono i fatti e, con l’aiuto di altri, riescono a far cessare il linciaggio. Una parte di questi saranno testimoni nel processo che ne seguirà.
Tutti i medici di Alessandria e di altre città si prestarono alle cure del prefetto.
Per fortuna, tra le tante varie ferite ed il sangue perduto, tuttavia il cranio del prefetto non venne sfondato, e dopo tante settimane di cure, si riprese ed allora fu istituito un regolare processo al monaco delinquente Ammonio ed agli altri suoi sodali.
Nella pubblica piazza ha luogo il processo e i giudici esaminano i fatti, ascoltano i testimoni, ricostruiscono l’intera vicenda di fronte al popolo riunito per ascoltare.
Viene poi pronunciato il verdetto di colpevolezza: “Gravissime lesioni, tentativo di omicidio nella persona del prefetto che rappresenta il potere dello Stato”. Tenuto conto che, la sola ribellione all’autorità pubblica, comporta la pena di morte, aggiungendo le gravi lesioni, il monaco Ammonio viene condannato al supplizio nella pubblica piazza, fino a che morte non ponga fine alla pena.
Il giorno del supplizio nella pubblica piazza, il comprensibile diverso modo di considerare la pena del supplizio, da parte dei vari cittadini presenti nella piazza, chi d’accordo perché giusta e meritata, chi invece la vede terribile, e chi (tra la parte più furiosa dei cristiani e fedeli al vescovo Cirillo, e da questo incitata), freme di rabbia e di odio ed invoca l’occasione per una vendetta perché “il sangue chiama sangue” … “il supplizio chiama supplizio”.
Per ordine del vescovo Cirillo, il corpo del monaco Ammonio, (uomo criminale e delinquente contro la persona del prefetto e contro le leggi dello Stato), viene lavato, ricoperto, vestito di seta e di broccato, cinto della corona dorata ed esposto alla pubblica adorazione dei cristiani nella cattedrale e con una messa, con il celebrante nella persona del vescovo Cirillo, incita la folla all’adorazione di Ammonio, che il vescovo chiama Thaumasios, cambiandogli il nome e promette vendetta in onore della fede alla Chiesa e nel nome di nostro Signore “venite adoremus”.
In verità non tutti i cristiani presenti sono d’accordo con il vescovo ed escono dalla chiesa, convinti che il rito che impone alla folla non abbia attinenza con la fede.
Il vescovo Cirillo alza le braccia al cielo, incitando la folla alla esaltazione verso il beato Thaumasios ed a baciargli i piedi, invocando la punizione divina sui nemici della Chiesa e la folla esaltata emette invocazioni e grida di guerra.
La filosofa Ipazia era tornata nella sua casa di campagna e quivi studiava e lavorava in una specie di idillio filosofico, ma il suo spirito irrequieto e le notizie che altri elleni avevano abbandonato la loro attività al museo, all’Università, al centro di Alessandria, determinarono in lei la necessità di ritornare in città.
I suoi collaboratori cercarono di convincerla a non farlo.
Così Demetra ed Antinoo, che assieme agli altri erano stati tutti affrancati, ma che non volevano abbandonarla e volevano proteggerla dal grande pericolo cui andava incontro, le dissero che il mondo della scienza e della filosofia, al quale lei era legata, stava scomparendo e che quelle moltitudini di cristiani e di ebrei erano una folla di invasati e fanatici che non erano in grado di ascoltare la più piccola voce della ragione ed erano pericolosi.
Lei però si convinse che, proprio per questo, non doveva abbandonare il suo posto di insegnamento e quindi doveva riaprire la sua scuola.
Ipazia ha infatti ripreso l’insegnamento al museo, ma si è subito accorta con angoscia che le stanze sono quasi tutte imbrattate, i vetri rotti, scritte volgari sui muri, vagabondi che si accampano in alcune aule. Non c’è più nessuno dei suoi colleghi di un tempo ad insegnare. Vi sono solo alcuni suoi studenti fedeli che non si separerebbero da lei; ed è per questo che si sente in obbligo di continuare ad insegnare, nonostante il pericolo che corre per come stanno le cose in città, per le bande dei monaci parabolani cui ricorre il vescovo Cirillo.
E’ il mattino di un giorno, apparentemente qualunque, mentre sta commentando un trattato, quando lascia cadere il volume che ha in mano e, guardando negli occhi i suoi allievi, inizia con loro un discorso.
Dice loro che probabilmente lei dovrà lasciarli e che la scuola probabilmente verrà chiusa e tutti i frequentatori dispersi e non sa che sorte toccherà a lei, anche se non ha paura di morire.
E’ vero che la vita è bella per chi sa apprezzare le sue bellezze, che allietano la vita delle persone, e le persuadono a continuare a vivere. Ma condizioni avverse possono condurre a momenti in cui è più dignitoso morire che continuare a vivere.
Ipazia è fortemente ansiosa per la sorte che toccherà, non tanto e non solo a lei, ma ai suoi allievi, che la guardano ammutoliti da questi discorsi. Rammenta che Socrate aveva lasciato i suoi allievi con animo più sereno di come li lascerà lei, giacchè lui visse in tempi e luoghi migliori.
Se la città di Socrate era stata ingiusta con lui, condannandolo a morte, tuttavia, era ancora una città sana, governata da buone leggi, tutelata da buoni costumi. Ed è per questo che Socrate non volle fuggire, come si sa, malgrado gliene venisse offerta l’opportunità, e non volle sottrarsi alla condanna, nel rispetto delle leggi di Atene.
Poi, dopo una pausa piena di opprimenti pensieri, alzando la testa e cercando gli sguardi dei suoi studenti, continua a parlare di un futuro pesante per loro, senza norme, leggi, costumi e né virtù che tutelino la loro moralità e che li educhino al bello e al buono.
Lei vede, infatti, un futuro nel quale i cristiani, nel nome di Dio, si spieranno, si denunceranno, si tortureranno, si uccideranno a vicenda e si aprirà un’epoca di tenebra opprimente sulla vita delle genti che vi saranno.
Saranno istituiti processi per un dogma, per una virgola, alle persone considerate come eretici, bruceranno vivi i malcapitati in nome della grandezza di Dio. Verrà trucidato chi non pensa esattamente come le direttive cristiane, religiose e politiche.
Ipazia ha una così sconcertante, quanto vera, previsione per il futuro che è prossimo, ma non solo prossimo.
Quanto potrà durare questo stato di cose, qualche decennio o qualche secolo? O anche più di mille anni? E ci sarà un enorme numero di persone, nell’ordine di milioni di individui, che non conosceranno altro che queste tenebre, e che, in altri luoghi del mondo ed in altri tempi, sulla terra risplendeva la luce, che dovranno invece vivere sotto il peso di una cappa fin dalla nascita, di un peccato da espiare per tutta la vita, dal divieto di vedere i corpi nudi perchè è peccato e quindi non si laveranno e vivranno fra le cimici e i pidocchi, in un sudiciume perenne in cui le malattie e la peste si trasmetteranno nelle chiese affollate, ove invocheranno il Signore, aiutati dai sacerdoti, giacchè la peste sarà considerata come comminata dalla divinità al popolo impenitente.
Poi Ipazia, nel rivolgere il saluto finale di chiusura ai suoi studenti, li invita a coltivare le proprie conquiste morali ed educative in futuro, facendo professione della saggezza e delle virtù che hanno imparato e di continuare a filosofare per le generazioni future.
Abbiamo già visto come il vescovo Cirillo abbia astutamente adoperato il processo e la condanna al supplizio del criminale Ammonio, facendolo diventare una vittima ed un beato e cambiandogli anche il nome, chiamandolo Thaumasios e cominciando ad adorarlo come un dispensatore di miracoli.
Allo scopo il vescovo vuole organizzare una processione e portare in giro il corpo del “Beato Thaumasios” per i quartieri popolari della città. Ma il prefetto Oreste, nel timore di disordini in città, vieta la processione.
Alla notizia del divieto, il vescovo Cirillo, si infuria e prende tutte le iniziative del caso.
Chiama a raccolta i suoi seguaci fidati ed i fedeli, nonché i monaci parabolani, che cominciano a riversarsi minacciosamente in città.
Il vescovo infiamma tutti contro il prefetto Oreste e contro la filosofa Ipazia e “incita a colpirli, in nome di Cristo”.
Il mattino, come gli altri giorni, Ipazia sta uscendo di casa e si reca al museo ove i suoi studenti aspettano per le consuete lezioni. Veramente quel mattino, sia sua madre Demetra e sia il suo amato Antinoo le sconsigliano di uscire e le ricordano che è in pericolo, ma le loro raccomandazioni non hanno effetto sulla fermezza di Ipazia.
Antinoo però segue la carrozza ove è salita la filosofa, ma non si accorge che, in maniera scaltra, è seguito da un monaco incappucciato che lo trafigge alla schiena con una lama accuminata, poi altri incappucciati gli sono addosso e la massacrano e fa appena in tempo ad urlare alla sua Ipazia di fuggire. Ma lei non fugge, scende dalla carrozza e guarda il suo amato morto con il corpo sfracellato, steso a terra. Vorrebbe abbracciarlo, ma una folla in delirio, inferocita, sta già sbucando dalle strade ad accalcare la presenza della banda di parabolani che hanno già cominciato a staccarle le vesti di dosso, sbeffeggiandola e tirandola per le braccia e per le gambe, trascinandola verso il Cesareo, il tempio dei cristiani, dove viene stesa sul sagrato con la folla festante contro “questa donna infedele”, le gridano insulti e sconcezze condite da risate oscene. Corrono intorno, calpestandola e saltando sul suo corpo con i piedi, come un branco di animali infuriati e la prendono a calci sul ventre, sul petto, sul viso.
Uno di quegli assassini le ha ficcato due dita nelle orbite ed è riuscito a cavarne fuori gli occhi, due globi sanguinanti. Poi iniziano a scarnificarla nella carne, dalla testa alle gambe, con le valve accuminate dei crostacei, fino a provocarle una morte lenta e dolorosa sul sagrato della chiesa “perché Cristo si appaghi del suo sangue e goda della vendetta della donna infedele che difende i pagani e gli elleni”.
Poi, un nutrito gruppo di parabolani indirizzata da Cirillo, ha forzato la porta della casa di Ipazia e, dopo aver malmenato il personale della casa, spalancano le porte, rovesciano i mobili, la libreria, devastano e distruggono tutto, poi salgono sulla torre, ove la filosofa si era molte e molte volte rifugiata a pensare e studiare il cielo, prima con suo padre Teone, poi da sola, lontana dai clamori del mondo, in questo suo luogo, sacro allo studio ed al sapere.
Quivi i monaci parabolani, in ossequio alla consegna del vescovo Cirillo, afferrano pergamene, modelli, disegni, tavole, volumi, gli scritti di Ipazia e distruggono tutto.
Non deve restare niente nel mondo cristiano, non solo del corpo di Ipazia, ma anche di tutto ciò che è stato di lei. Tutto devesi distruggere, bruciare, affinchè si perda ogni ricordo, così il vescovo sarà contento perché Cristo Re ha vinto.
Poi la storia cristiana farà santo e dottore della Chiesta il vescovo Cirillo di Alessandria.
Quanti Francesco ci vorranno per chiedere scusa e perdono alla storia dell’umanità delle persone?