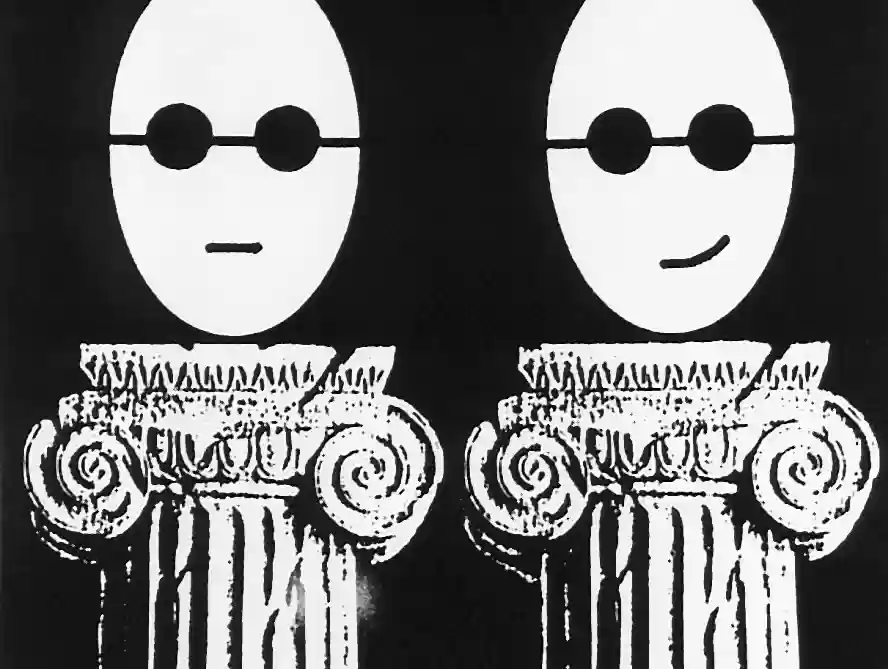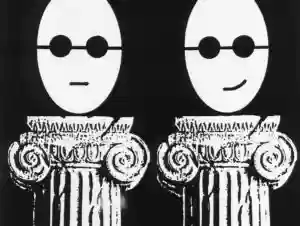
Tratto da lavoce.info
di Simone Pellegrino, professore associato di Scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche (ESOMAS) dell’Università di Torino
Negli ultimi mesi si sono succedute svariate proposte di revisione dell’imposta sulle persone fisiche. Ad alcune però sembra mancare una visione d’insieme coerente. Perché non è il numero delle aliquote a determinare l’efficacia di un’imposta.
Le proposte non mancano
Dopo la pausa estiva si è ripreso a discutere, al momento solo per sommi capi, di alcune possibili linee di intervento per la riforma del sistema tributario e dell’Irpef in particolare. Sembra che si navighi ancora a vista. Alcune proposte, formulate anche da alti esponenti del Governo, non sembrano avere una visione d’insieme, come l’estensione della cedolare secca sui canoni di locazione e l’abbassamento della rispettiva aliquota. Altre proposte sono invece più organiche – come quella di Longobardi, Pollastri e Zanardi – e altre ancora di vedute più generali, mentre si attendono i lavori della Commissione per la riforma fiscale dell’Ordine dei commercialisti, coordinata da Carlo Cottarelli.
In un recente articolo abbiamo discusso come l’Irpef e i suoi effetti di equità e di efficienza dipendano da tre fattori: la base imponibile, le aliquote e le detrazioni per lavoro e famiglia. Il vero tassello mancante continua ad essere un serio dibattito sulla base imponibile, che qui non si discute più. Molta eco ha avuto la proposta di riformare l’imposta in direzione di una progressività continua, sulla scia del sistema tedesco. E sui giornali spesso si legge a chiare lettere che il sistema in questo modo garantirebbe un’aliquota “personalizzata” per ogni contribuente. In realtà le cose non stanno proprio così. I tecnicismi per generare progressività dell’imposta personale sono più d’uno. In Italia dal 1974 applichiamo una progressività per scaglioni accompagnata da una progressività per deduzione o detrazione. Questa struttura, chiaramente, determina già un’aliquota media per ogni contribuente.
Si fa presto a dire progressività
Dal punto di vista teorico, invece, la progressività continua definisce ex ante una forma funzionale per l’andamento dell’aliquota media al variare del reddito. Questo tipo di progressività non è nuova per il nostro paese. L’imposta complementare sul reddito, introdotta nel 1923 e rimasta in vigore fino al 1973, era caratterizzata proprio da una progressività continua (l’aliquota media si determinava da un polinomio contenente la radice quadrata del reddito imponibile) che, dal 1958, prevedeva un’aliquota media crescente dal 2 al 65 per cento. Tale imposta, tuttavia, era in grado di garantire un gettito non elevato (circa il 4 per cento delle entrate tributarie correnti nel 1972), poiché applicata solamente ad un quinto dei contribuenti complessivi.
Il passaggio a un sistema di questo tipo può comportare svantaggi di comunicazione tra fisco e contribuenti: l’utilizzo di un polinomio per il calcolo dell’imposta potrebbe generare dubbi sulla sua chiarezza da parte di molti contribuenti, che avrebbero però il vantaggio di leggere immediatamente il loro debito di imposta, senza doversi districare con un sistema che oggi è troppo articolato. Ormai, inoltre, l’amministrazione finanziaria è in grado di produrre adeguati software per il calcolo dell’imposta (si pensi al 730 precompilato). Questo tipo di progressività può produrre anche vantaggi: è in grado per esempio di tenere maggiormente sotto controllo l’andamento dell’aliquota marginale effettiva al variare del reddito, andamento che è più erratico nel sistema attuale, a causa dell’interazione tra aliquote marginali legali crescenti col reddito e detrazioni per lavoro e famiglia decrescenti. Se però l’aliquota media servisse solamente per il calcolo dell’imposta lorda, ovvero senza considerare le detrazioni, la semplicità del sistema verrebbe ridimensionata, a meno di introdurre contemporaneamente un sistema come l’assegno unico per le famiglie, slegato cioè dalla struttura dell’imposta.
La proposta di Longobardi, Pollastri e Zanardi va in questa direzione. È molto articolata e si caratterizza per l’applicazione di diverse aliquote medie, una per ogni tipologia di lavoro, che inglobano nel calcolo non soltanto le attuali aliquote legali, ma anche le detrazioni per lavoro; la proposta, contestualmente, prevede l’eliminazione del “bonus Renzi”; poiché le attuali detrazioni per famiglia dovrebbero essere sostituite dall’assegno unico per i figli, in fase di studio, dalla proposta in esame rimarrebbero fuori solamente le detrazioni per oneri perché specifiche per ogni contribuente. Sarebbe quindi una struttura impositiva in grado di ripulire le irregolarità oggi esistenti, in primo luogo l’andamento delle aliquote marginali effettive. Oltre alle condivisibili caratteristiche appena descritte, la bontà tecnica della proposta risiede nella costanza di quella che in termini tecnici si chiama residual progression, ovvero il rapporto tra la variazione percentuale del reddito netto e la variazione percentuale del reddito lordo per la stragrande maggioranza dei contribuenti. Il parametro in oggetto può essere modificato a piacimento per definire l’intensità dell’effetto redistributivo desiderato. Un sistema basato quindi su pochi parametri, molto elastico, tecnicamente semplice, anche se matematicamente complesso ai più.
Le criticità
C’è poi un altro aspetto che non può non essere oggetto di riforma: il “bonus Renzi”, recentemente esteso, riguarda ormai la maggior parte dei lavoratori dipendenti e non è più una misura razionale, a meno di non voler completamente ridimensionare nel tempo il ruolo dell’imposta personale. Deve quindi essere ricondotta all’interno della struttura d’imposta. Il problema è prettamente politico: eliminare il bonus e sostituirlo nell’Irpef genera contribuenti perdenti e vincenti, caratteristica che rende difficile parlare di questo tema. Sono state proposte anche riforme in grado di superare questi problemi. Non tutte le parti politiche sono però concordi sulle linee guida da seguire. Alcuni preferirebbero una revisione della scala delle aliquote. L’ipotesi più discussa è il passaggio dall’attuale sistema con cinque aliquote ad un sistema con meno aliquote, finanziandolo parzialmente con l’auspicabile taglio delle detrazioni per oneri.
Le risorse in gioco non sembrano però essere molte, tra i 5 e i 10 miliardi di euro (e peraltro si moltiplicano le voci di un rinvio della riforma a partire dal 2022). L’ipotesi di ridurre gli scaglioni sarebbe probabilmente più costosa in termini di gettito. Con questi numeri, e per perseguire l’obiettivo primario e condivisibile di ridurre le imposte sul ceto medio-basso, lo scenario più concreto potrebbe essere quello di un aumento delle aliquote da cinque a sei, scorporando l’ampiezza del terzo scaglione e riducendo l’aliquota dall’attuale 38 al 32 per cento nella prima parte, come recentemente proposto.
Ma non è tanto il numero delle aliquote che determina la bontà di una imposta, anche perché sottostanti queste scelte ci sono, da una parte, giudizi di valore che devono essere condivisi dalla collettività e, dall’altra, vincoli di gettito. Per esempio in origine l’Irpef era caratterizzata da 32 scaglioni, ma la quasi totalità dei contribuenti rientrava nei primi dieci, generando una progressività più formale che sostanziale. Non è quindi tanto lì il punto. Riformare non vuol dire sempre e comunque rivoluzionare. Riformare vuol dire prendere atto delle problematiche attuali e porre rimedio in modo equilibrato.