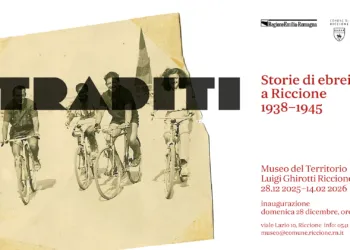di Daniele Morritti
– Una sovrana illuminata, una donna – tra le prime – a intravedere nel pluralismo culturale la sagoma bronzea di quella che il poeta Lamartine ebbe a definire, in occasione delle rimostranze popolari pre-rivoluzionarie che scossero l’Europa di Vestfalia sul finire del XVIII secolo, “la campana del mondo”.
Ma anche una dissidente, una suffragetta ante-litteram che amava presiedere, in barba ad ogni principio salico, i consessi politici senza alcun timore, una poliglotta a proprio agio con gli autori latini, così come con i cantori della cristianità. In definitiva, una politicante tout-court, colta ma non per questo estranea al sotterfugio, invero agli istinti belligeranti che per secoli hanno mosso le azioni – e le intenzioni – dei governanti europei facendo dei crinali collinari e delle fertili pianure del Vecchio Continente un cimitero senza confini.
Questo e altro è stata Cristina di Svezia, sul trono che fu di Gustavo II Adolfo dal 1644 al 1654, quando abdicò in favore del cugino Carlo. Una scelta, quella di Cristina, senz’altro dettata dal disagio provato per gli abiti stretti entro cui l’ortodossia luterana, nonché la prospettiva matrimoniale, l’avevano costretta, preferendo in definitiva un’apostatica conversione al cattolicesimo papale. Un atto sedizioso che la spinse a errare oltre i confini svedesi, in quella che si pone a metà strada tra una missione politica – l’obiettivo, neanche troppo implicito, di defenestrare i sovrani spagnoli dal Regno di Napoli con l’aiuto dei francesi – e la ricerca spassionata di sé, bohémien se vogliamo.
Giancarlo Mantellato qualche anno ha ricostruito l’itinerario di Cristina per le vie d’Europa – al cui seguito, ricorda, procedeva affilata una “carovana” di oltre 250 adepti – cosìcché il 2 dicembre 1655, dopo aver penetrato quella che solo in seguito verrà compendiata come la Mitteleuropa, l’ormai ex Sovrana di Svezia entrava a Rimini, accolta dal fragore e dalle grazie cerimoniali riserbatole appositamente da Papa Alessandro VII.
A precedere l’avvento di Cristina in Romagna, naturalmente, la sua conversione. Non sembra azzardato definire la venuta italica di Cristina come un secondo e ben più mediatico battesimo.
Mantellato rammenta che alla volta di Pesaro, Cristina ebbe a consumare un pasto a base di “confetture e paste di zucchero” nella ridente Cattolica, prima che il Cardinal Legato, l’anfitrione scelto dal Pontefice, l’accompagnasse al confine verdeggianti col Ducato d’Urbino.
Nel 1656, a un anno esatto dal primo viaggio in terra romagnola, le congetture militari e i tatticismi politici riportano Cristina in Italia (al tempo sferzata, come suggeriscono le cronache dell’epoca, da un’epidemia di peste, l’ennesima). A Pesaro, l’ex sovrana trova modo di dilettarsi nella coltura del puro ozio, impressionando i suoi ospiti per la disinvoltura con la quale ammicca al culto dell’“astrologia” senza per questo dimenticare le sacre scritture.
Tuttavia, grazie al combinato disposto tra ambizioni napoletane e latitanza del Mazzarino (“Non ricevendo notizie dal Cardinale […]”), Cristina è giocoforza costretta al rientro in Francia. Sulla via del ritorno, in prossimità della Siligata, la carovana “è presa in consegna presumibilmente dagli Agolanti”, marchesi arciunesi (riccionesi). A Rezzone (sempre Riccione), Cristina sconta la contumacia alla quale la peste divampata a Roma stava costringendo popolani e nobili, senza distinzione di sorta. Un carteggio dell’epoca così recita: “non le giovò dunque l’altezza del suo grado e dovette uniformarsi alle esigenze della comune salute”.
Come sagacemente suggerisce Mantellato, non resta da chiedersi come Cristina “ingannò il tempo” in quel crudo frangente. Di certo sappiamo che Cristina di Svezia ha ingannato il tempo ovunque, anche a Rezzone. Dal 21 giugno al 9 luglio del 1656. Chissà se fece mai il bagno.