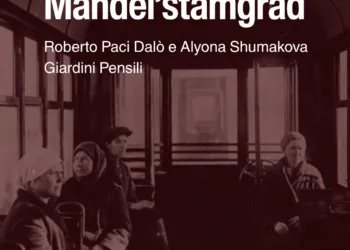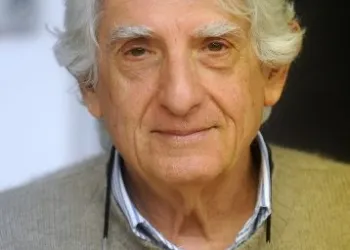di Fausto Bersani*
– Cari lettori, vi accompagnerò in tre puntate dedicate ad altrettante emergenze ambientali che, da fisico, considero gravi a livello di rischi ed urgenti in termini di tempi di reazione. Oggi parleremo del tentativo di ritorno al nucleare avanzato dal Governo italiano il quale, assecondato da una stampa compiacente e da presunti esperti, spesso affetti da conflitti di interesse, si è prodigato nel tentativo di cortocircuitare l’esito dei referendum del 1987 e del 2011 a seguito dei quali l’Italia chiuse le centrali esistenti e decise di fermare i piani del governo per costruirne di nuove.
Il 28 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega che, una volta ratificato dal Parlamento, permetterà al Governo di adottare entro dodici mesi i decreti attuativi necessari a disciplinare il “nuovo nucleare”. Un profilo preoccupante della nuova legge è rappresentato dal fatto che le centrali nucleari diventerebbero opere di interesse nazionale per cui sarebbero soggette all’autorizzazione unica del Governo fatta salva la Valutazione di Impatto Ambientale, ma sappiamo tutti benissimo come finiscono, in genere, questi percorsi…
Dal momento che a me interessano i dati oggettivi, non aggirabili da argomentazioni ideologiche, vediamo di capire perché questa scelta non è sostenibile a livello ambientale e sanitario né conveniente sul piano economico.
Innanzi tutto va detto che in Italia erano state costruite 4 centrali a partire dagli anni ‘60, chiuse dopo il 1987 e, ad oggi, non sono ancora stati trovati siti definitivi per il deposito delle scorie.
Entro il 2025 è previsto il ritorno, sul nostro territorio, di oltre 235 tonnellate di scorie radioattive ad alta pericolosità temporaneamente parcheggiate in Francia e Regno Unito, un’operazione per la quale abbiamo pagato, dal 2001 ad oggi, circa 1,2 miliardi di euro: l’Italia non sa dove metterle e non ha un deposito adatto per custodirle in sicurezza per tempi dell’ordine di decine di migliaia di anni. Solo negli Stati Uniti, ogni anno, vengono spesi circa 500 milioni di dollari per la gestione delle scorie nucleari di circa 100 centrali ad uso civile. Questi costi sono destinati ad aumentare man mano che i rifiuti continueranno ad accumularsi.
Dopo la cessazione di attività degli impianti, i quali è bene sapere che non hanno vita illimitata , la spesa dovrà continuare per migliaia di anni senza alcun flusso di entrate dalla vendita di elettricità solo per pagare lo stoccaggio. Inoltre più scorie nucleari si accumulano maggiore è il rischio di fughe radioattive che possono danneggiare l’approvvigionamento idrico, i raccolti, gli animali e l’uomo.
Ufficialmente nel mondo sono state prodotte 260 tonnellate di plutonio (tempo di dimezzamento oltre 24000 anni), una quantità che, di fatto, sembra irrisoria. Tuttavia è bene sapere che la dose cancerogena per un essere umano è un milionesimo di grammo: questo equivale ad oltre 32000 dosi cancerogene a testa per ognuno degli 8 miliardi di abitanti del pianeta. Stiamo parlando dell’elemento più tossico dell’universo da vigilare per decine di migliaia di anni. Se accade un grave incidente (e purtroppo può accadere, come sappiamo), gli effetti non hanno confini nello spazio e nel tempo, quindi i danni sono totalmente imprevedibili.
Gli Stati Uniti, la nazione più ricca e tecnologicamente avanzata del mondo, piena di luoghi a bassissima densità abitativa, non ha ancora trovato un deposito definitivo per la messa in sicurezza delle scorie nucleari ad alta attività. Il progetto Yucca Mountain è stato definitivamente abbandonato nel 2009, dopo decenni di studi e un fiume di miliardi spesi.
In Italia sono state individuate inizialmente addirittura 67 aree potenzialmente idonee, poi ridotte a 51, in 6 diverse regioni, e da queste dovrebbe essere selezionato il Deposito Nazionale. Al momento pare che nessuna delle aree coinvolte abbia espresso parere favorevole alla costruzione del sito. Teniamo presente che il 94% del nostro territorio è a forte rischio idrogeologico e/o sismico, il primo aggravato poi dall’emergenza climatica che affronteremo in un’altra puntata. Non si può non riconoscere a questo proposito l’attualità della frase di A. Einstein quando affermò…”Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi”.
L’analfabetismo scientifico dell’esecutivo si manifesta purtroppo anche sotto altri aspetti: i cosiddetti mini reattori, ossia il cavallo di Troia del ritorno al nucleare. Non a caso il nostro Governo, rilanciando il nucleare made in Italy, dichiara di non voler puntare sulle grandi centrali, bensì su mini centrali – Small Modular Reactor (SMR) – con potenze dell’ordine di circa 30 – 300 MW che si potrebbero realizzare in serie, in fabbrica, e successivamente assemblare nei diversi siti. Peccato che il primo progetto di Small Modular Reactor, made in USA, sia fallito ben prima di emettere il primo vagito…ma andiamo per gradi: il nucleare, per essere efficace, dovrebbe coprire una richiesta minima di potenza al di sotto della quale in Italia non si scende mai in nessun momento dell’anno, il cosiddetto “base load”, pari a circa 25 GW di potenza. Un’ipotesi è quella di costruire almeno 10 centrali di grossa taglia (1-2 GW l’una) in una decina di siti…e comunque non sarebbero sufficienti. Costi stimati sulla base dei cantieri esistenti, peraltro in zone già attrezzate in Europa e negli USA, oltre 100 miliardi di euro con tempi di realizzo, per essere ottimisti, circa 20 anni. La Cina ha prodotto 55 GW di nucleare dal ‘92 ad oggi, ma ha generato più di 200 GW fra eolico e fotovoltaico in 1 anno e l’obiettivo è raggiungere 1200 GW entro il 2030, giusto per dare una misura del confronto, a livello di investimenti, tra fonti rinnovabili e nucleare. Un’alternativa sarebbero appunto i mini reattori: ce ne vorrebbero però almeno 100 da circa 200 MW l’uno, in pratica un mini reattore per ogni provincia italiana…ve lo immaginate cosa significhi?… un progetto decisamente insostenibile. La presunta necessità di un ritorno al nucleare, nella migliore delle ipotesi, è una posizione puramente ideologica sostenuta da alcuni politici che si sono improvvisati scienziati leggendo qualcosa su qualche social. La narrazione ottimistica a questo proposito è stata smentita anche da un recente report dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Il progetto più avanzato di un reattore modulare era quello di NuScale, una società made in USA che sviluppa e commercializza mini reattori che, tra l’altro, aveva anche ricevuto l’approvazione dagli enti regolatori e che programmava di costruire una serie di sei reattori in Idaho. Il progetto è stato cancellato nel novembre 2023 perché l’esplosione dei costi lo aveva reso antieconomico: in pochi anni i costi di realizzo sono lievitati da poco più di 5 miliardi di dollari a 9,3 miliardi ed i finanziatori, ovviamente, si sono dileguati. Questo senza nemmeno aver iniziato la costruzione nonostante il finanziamento di centinaia di milioni di dollari da parte del governo federale americano.
Altro problemino non trascurabile: gli SMR, come la maggior parte dei reattori nucleari, hanno bisogno di grandi quantità di acqua per il raffreddamento del nocciolo. A causa del riscaldamento globale (come vedete il quadro è complesso coinvolgendo più settori contemporaneamente) si possono presentare importanti criticità. La Francia è stata recentemente costretta, in alcuni periodi, a ridimensionare fortemente la produzione di energia a causa della siccità che ha colpito la Loira sottraendo acqua ad altre destinazioni vitali per non subire la stessa sorte in cui è incorsa la centrale di Fukushima, anche se per altri motivi. Inoltre l’acqua calda che esce da una centrale perturba l’ecosistema per non parlare di microfuge radioattive con pesanti conseguenze croniche sul piano sanitario, anche se silenziose a livello mediatico.
A questo punto si aprirebbe un discorso molto lungo e tecnico; per chi è interessato lascio delle indicazioni nelle note a piè di pagina per approfondimenti . In questa sede mi limito solo a fornire alcuni spunti basilari di un tema spesso trascurato nel dibattito sul nucleare, ossia l’impatto sulla salute umana dei radionuclidi emessi dalle centrali nucleari in condizioni di normale funzionamento. Nel 14° Rapporto del Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment (COMARE) vengono minuziosamente elencati tutti i quantitativi di differenti radionuclidi emessi dalle centrali inglesi, tedesche, svizzere e francesi in tre anni (1999, 2000 e 2001). Questo a conferma della reale emissione continua di radionuclidi da parte degli impianti nucleari. La loro azione va valutata considerando che questi, una volta emessi a piccole dosi, vengono dispersi in tutto l’ambiente circostante (aria, acqua, terra) dove permangono a lungo accumulandosi e da qui possono essere assunti, tramite gli alimenti e la respirazione, dagli organismi viventi. In pratica vengono concentrati progressivamente in organi critici del corpo irraggiando i tessuti attraverso radiazioni ionizzanti continue per periodi di tempo anche molto lunghi (mesi/anni). I risultati sono focolai territoriali, statisticamente significativi, di leucemie ed altre forme tumorali che, a seconda dei casi, si possono estendere anche per decine di chilometri dalle centrali. Criticità sistematicamente taciute o, quanto meno, sottostimate.
Tornando agli SMR si sappia anche che, a parità di energia fornita, questi reattori produrranno rifiuti chimicamente e fisicamente più reattivi e molto più voluminosi degli omologhi nei grandi impianti, per un fattore da 2 a 30 volte, aggravando ulteriormente la criticità dello stoccaggio delle scorie.
Le verità, per quanto riguarda l’interesse verso i mini reattori, in realtà, sono altre rispetto a quelle propagandate: la spinta verso questa tecnologia nasce dal settore militare e riguarda l’ammodernamento delle flotte di sottomarini, portaerei, ma anche incrociatori e fregate a propulsione nucleare. Non è un caso se gli SMR esistono da decenni nell’industria militare, ma non sono stati mai autorizzati ad uso civile per ragioni di sicurezza. Durante il suo decadimento, l’Uranio genera sottoprodotti come Plutonio ed Uranio impoverito utilizzati proprio nel settore militare. Un altro ambito, oltre a quello militare, estremamente energivoro e fortemente interessato alla densificazione territoriale del nucleare di piccola taglia è quello dell’Intelligenza Artificiale: nel 2024 sono stati stipulati accordi dagli oligarchi del web, ossia le compagnie big-tech che monopolizzano l’offerta informatica dell’AI, con le aziende in grado di realizzare reattori nucleari per far fronte alla gigantesca quantità di energia elettrica richiesta. Infatti lo sviluppo delle intelligenze artificiali e del cosiddetto cloud computing richiede un consumo di energia elettrica circa 30 volte maggiore di quello necessario per i classici motori di ricerca. Secondo alcune stime, entro il 2030, l’AI potrebbe rappresentare il 3-4 % della domanda mondiale di elettricità. Una fuga in avanti per soddisfare un fabbisogno energetico illimitato, una sorta di “intossicazione energetica”, così come giustamente l’ha definita da Yves Marignac, esperto dell’autorità francese per la sicurezza nucleare.
Accantonando gli SMR, l’altra tecnologia, quella battezzata di quarta generazione con reattori autofertilizzanti raffreddati a metalli fusi, sulla quale il governo si avventura in modo disorientato e farraginoso, ha una storia tutta da scrivere. Basti pensare al reattore francese Superfenix, chiuso nel 1997, o ricordare che cosa è accaduto a Monju, in Giappone, dove la produzione commerciale di energia è durata una sola ora con il reattore chiuso definitivamente nel 2016. In entrambi i casi si sono presentati gravi incidenti che ne hanno compromesso la sicurezza. Stiamo parlando di una tecnologia ancora tutta da sviluppare che non sarà disponibile, a livello commerciale, prima del 2040.
Un altro falso mito da sfatare riguarda il tema della CO2: l’Europa ha fissato al 2050 il raggiungimento della neutralità climatica. Un obiettivo ambizioso che è racchiuso nella strategia chiamata Green Deal Europeo, volta ad abbattere le emissioni di gas serra come la CO2 e a contrastare l’emergenza climatica. La visione della Commissione Europea è in linea con l’accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 in cui si poneva l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 2°C (meglio ancora se sotto a 1,5°C) e di raggiungere il traguardo delle emissioni zero entro il 2050. A questo proposito spesso si sente dire che il nucleare non genera anidride carbonica, affermazione complessivamente corretta durante la fase produttiva, ma se andiamo ad analizzare la filiera dell’intero ciclo, dall’estrazione dell’Uranio alla costruzione di nuove centrali fino alla loro dismissione vediamo che il nucleare, a parità di energia prodotta, genera una quantità di anidride carbonica 40 volte superiore all’idroelettrico, 15 volte superiore all’eolico e circa 4 volte superiore al fotovoltaico. Quindi non solo i costi ed i tempi di realizzo non depongono a favore del nucleare rispetto alle principali energie rinnovabili, ma neanche gli obiettivi della sempre più urgente transizione ecologica.
E che dire dell’indipendenza energetica/geopolitica? Non abbiano Uranio in Italia, né tecnologie per trattarlo. Il 43% della materia prima viene estratta in Kazakistan e la parte restante principalmente in Canada, Namibia, Niger, India, Russia, Ucraina ed Australia. Inoltre i costi dell’Uranio negli ultimi anni sono aumentati del 140%. La tecnologia di arricchimento, a sua volta, è largamente nelle mani di Russia e Cina. Quasi tutti i reattori del pianeta, compresi gran parte di quelli francesi e americani, sono alimentati con barre d’Uranio prodotte dal colosso russo Rosatom che, non a caso, è stato escluso dalle sanzioni dopo la guerra in Ucraina. Sposteremmo semplicemente la dipendenza dal gas ad un’altra fonte geopoliticamente instabile …e qualcuno ha il coraggio di definirla “indipendenza”.
Un’ultima osservazione riguarda il Santo Graal dell’energia nucleare: la fusione nucleare, sulla quale, mi si perdoni il gioco di parole, c’è molta con-fusione (la tentazione era troppo forte). Chi pensa che questo tipo di reazioni che avvengono all’interno delle stelle, come ad esempio nel nostro Sole, siano facilmente trasferibili a livello tecnologico si sbaglia di grosso. Si stima che serviranno almeno 30/40 anni per portarle a livello produttivo: oggi le reazioni di fusione riusciamo a mantenerle per circa 5 secondi. Altro grave problema: le scorte mondiali di trizio, elemento base per questo tipo di processo, ammontano a soli 27 kg…in altri termini bastano per un solo reattore.
Come giustamente osserva Nicola Armaroli (Research Director presso il CNR), non c’è nessun boom nucleare in corso: dal 1996 ad oggi la percentuale di elettricità prodotta da nucleare nel mondo è passata dal 17.6% al 10,1%. Nel 2021 sono stati disconnessi 8 reattori a fronte di 6 nuove accensioni. Per non parlare dei due reattori di Virgil Summer il cui progetto è stato cancellato dopo aver speso nove miliardi di dollari, per produrre nulla, riversati sulle bollette degli utenti della Carolina del Sud. L’incremento delle bollette in ogni caso è da mettere in preventivo dal momento che il nucleare e la relativa gestione delle scorie necessita di sovvenzioni statali. Quindi sui propositi a lungo termine è inevitabile essere scettici perché se c’è un settore che da decenni, sistematicamente, non raggiunge i propri obiettivi di espansione, questo è proprio il nucleare mentre le fonti rinnovabili hanno diminuito costi e tempi di realizzo attraendo gli investitori, dagli USA alla Cina. I dati forniti dall’International Energy Agency (IEA), nel suo Energy Outlook 2024, sono assolutamente chiari: i costi dell’elettricità dovuta al nucleare sono, in media, tre volte maggiori dei costi delle rinnovabili e, secondo i calcoli dell’agenzia, fino al 2050 i costi di generazione delle rinnovabili nell’Unione Europea si manterranno sempre più bassi rispetto al nucleare.
Costruire una centrale nucleare fra 20/30 anni sarà come entrare oggi in un negozio di elettronica e chiedere una TV a tubo catodico, significa essere al di fuori della storia. Prima di discutere di un ritorno all’energia nucleare in Italia andrebbero affrontate scientificamente numerose criticità come tempi di realizzazione, costi, dipendenza tecnologica e geopolitica, impatti ambientali e sanitari e, non ultima, l’agenda di decarbonizzazione, totalmente disallineata rispetto ad un programma nucleare basato sulla costruzione di prototipi propagandati in modo entusiastico ed ottimistico da politici che parlano di cose che non conoscono.
*ISDE Italia
Federconsumatori Rimini